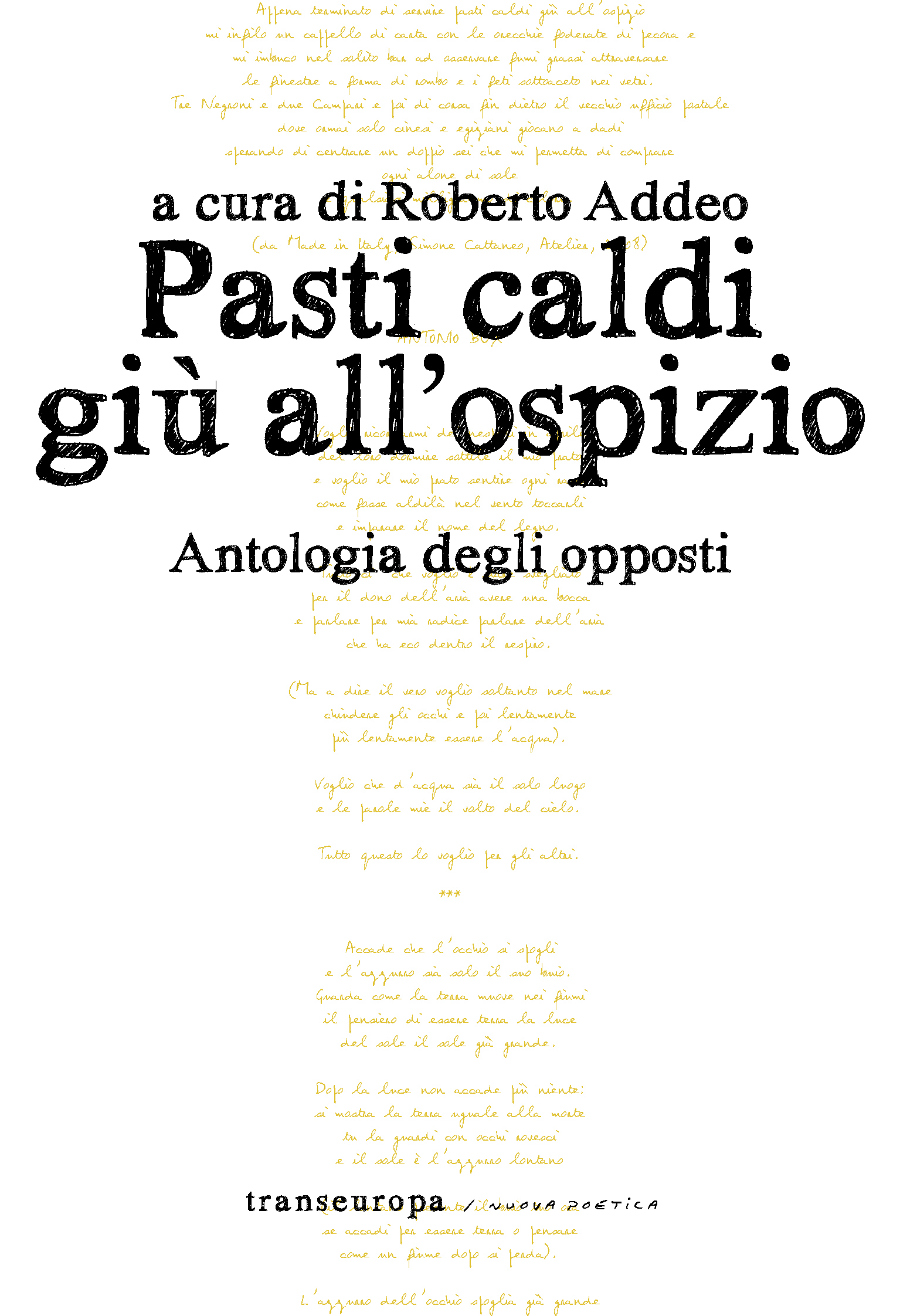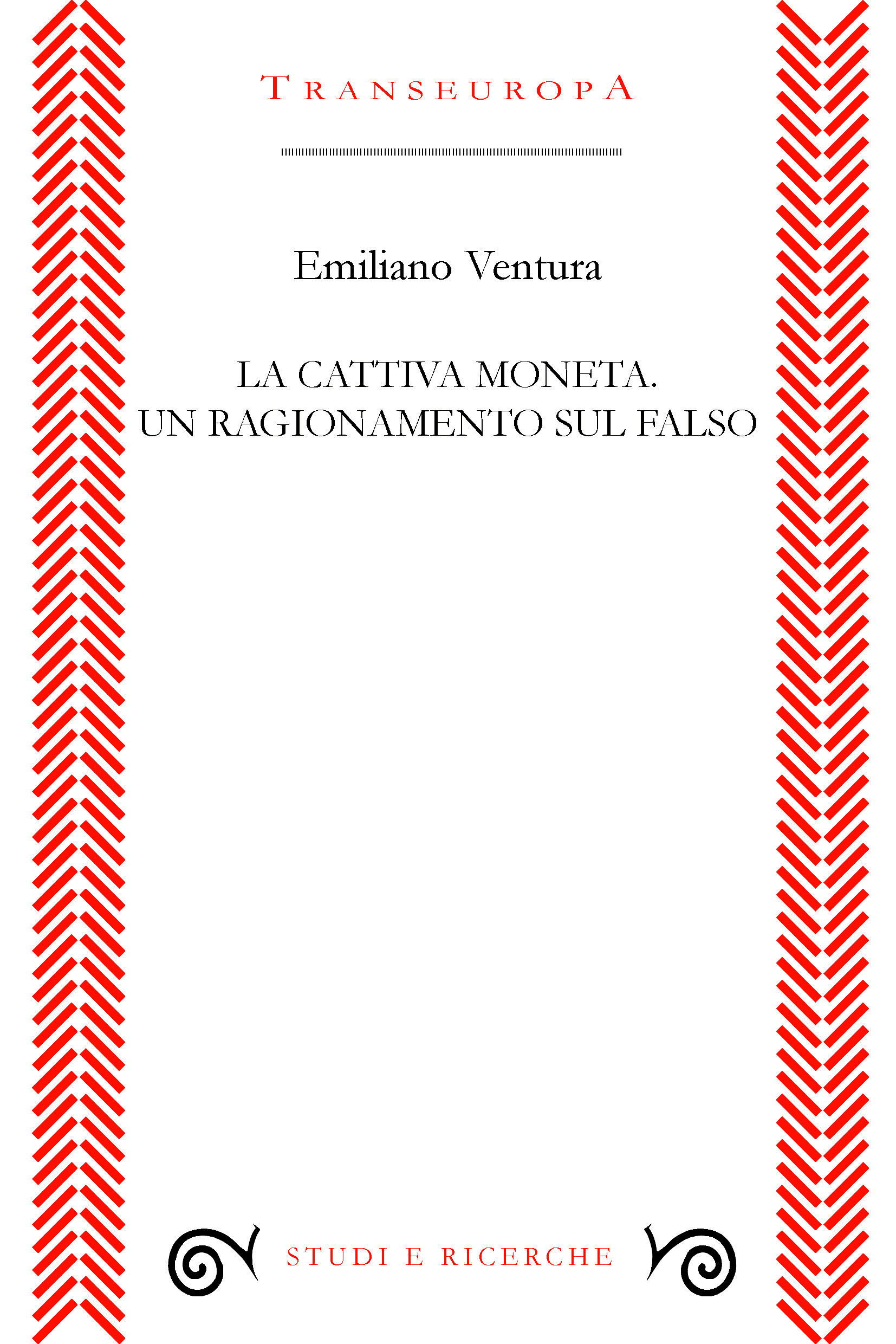Tu, se sai dire, dillo, dillo a qualcuno
Alcuni anni fa Gianluigi Simonetti, parlando dell’uscita per Mondadori della raccolta di tutte le poesie di Milo De Angelis, scriveva che “Mai come oggi il timore sconvolgente, e per questo inconfessabile, è che una lirica perfetta, ambientata nella nostra lingua e nella nostra vita, non si possa più né leggere né scrivere: non per mancanza di talento dei singoli poeti, ma per una disabitudine collettiva, sociale, alla verticalità, alla concentrazione, all’ascolto della lingua”. E aggiungeva però che per fortuna e per ristretto che sia il suo pubblico, “si può ancora scrivere grande poesia – anche se forse questa pienezza di forma e di significato non la sopportiamo e non la meritiamo più”.
Queste parole mi sono tornate in mente leggendo – si parva licet componere magnis, come si usa dire in questi casi – prima in fase di redazione e poi una volta pubblicate, le liriche che compongono la prima parte de Il sentimento non dicibile dell’oggi di Francesco Scapecchi, pubblicato dalla casa editrice Transeuropa nel 2022. L’ingiunzione a scrivere questo testo, dichiarata fin dalla citazione in exergo – “Bisogna affrettarsi se si vuole ancora vedere qualcosa, perché le cose sono in procinto di scomparire” – attribuita al tardo Cézanne, muove dall’urgenza di appropriarsi della realtà, della trama degli oggetti che la strutturano, già a noi in larga parte illeggibili, ma forse non ancora perduti. Si potrebbe dire che il senso di questa ricerca verbo-visiva è il tentativo di decifrare quel segreto in piena vista che è la nostra abulica adesione a un mondo che funziona ma che non è possibile abitare, che si sfilaccia e si sfibra di continuo e che tuttavia dura (e noi con esso) perché non cessa di finire.
Manca l’ io lirico, completamente, in questa raccolta in cui abbondano invece i verbi impersonali e un insistito e indefinito “noi”, che è al contempo invito all’assunzione di responsabilità e disperata constatazione della compartecipazione generale a una debilitante immobilità: “la nostra continua replica non ci rattrista, | essere sempre più io non ci fa male, | dove niente piace più di un’opinione | la nostra scelta masochista ci occultiamo | con una depressione | cui non sappiamo dare volto, nome” (p. 15). Il fuori come domanda, il fuori come l’impossibile necessario è il grande tabù di cui questo volume interroga la mancanza. “Non temere il proprio tempo è un problema di spazio”, cantavano i CSI quasi 30 anni fa. Erano i tempi dell’ubriacatura post-moderna da fine della storia; erano anche i tempi in cui era ancora possibile fare esperienza di un mondo, e dunque immaginarne persino un altro, lottare per la sua venuta. L’uno e l’altro – questo ci consegna lo sguardo del poeta di vedetta – sono stati annientati dalla moltiplicazione digitale degli schermi, degli sguardi e degli specchi che hanno fagocitato quindi anche la dimensione del tempo come spazio altro da abitare o da conquistare. Compito limitato (ma eticamente necessario) che la poesia può assumersi, diventa allora quello di articolare il discorso funebre di un decesso non dichiarato, “nell’interstizio tra la detonazione e il sacrificio”: “Qui un tempo piatto, veloce solamente | come una promessa che non si mantiene.”; “la percezione del tempo | è avariata; trasecola e cola nei minuti | frullati ogni complessa vertigine” (p. 8).
Siamo così investiti da un dettato poetico che procede per illuminazioni e lampi: i testi sono tutti senza titolo, assai eterogenei per lunghezza e disposizione grafica sulla pagina, in un flusso visionario che è sia giudizio oracolare di condanna della realtà delle cose che ansia di aderire linguisticamente al suo statico agitarsi, alla sua convulsa emissione di parole “imposte impestate masticate” (p. 16). Il problema non è più, sembra dirci Scapecchi, che il mondo non può essere colto e detto se non per frammenti; il punto è, semmai, che la cattiva totalità che ci sovrasta si regge su una sovrabbondante produzione e sulla caotica disseminazione di segni. I quali, pongono in una inesauribile e reciproca tensione il bisogno di individuare i contorni delle cose e l’esigenza di rappresentare con la parola la velocità della consunzione ininterrotta a cui rischia di ridursi la loro essenza. La raccolta, bipartita in due sezioni intitolate non a caso “in realtà” e “la posizione delle cose”, sembra porsi proprio su questo crinale, ambendo a farsi strumento di sottrazione al sortilegio di “un’idea che si svuota | nel dirla ad alta voce | nel mentre la violenza occulta la sua traccia” (p. 7).
Da qui l’insistita presenza dell’allitterazione, di rime interne atte a restituire il senso della corsa affannosa del linguaggio per tener dietro a una realtà sfuggente, come pure della paronomasia, anch’essa assai utilizzata per dar conto della proliferazione dei significanti l’uno dall’altro nel vortice sterile dell’infodemia, di contro all’immobilità delle cose e alla difficoltà a metterle a fuoco. Ne risulta uno stile nervoso ed espressionista – “in cigolii si può meglio, forse, dire il vero”(p. 54) – il cui modello è da rintracciare nella poesia di Balestrini (specie per il diffuso ricorso all’iterazione, a contrassegnare la mimesi dei processi di accumulazione e consumo) a cui subentra soprattutto nella seconda parte il richiamo a uno sperimentalismo più intellettualistico nel solco di Sanguineti. Per quanto non un solo verso alluda esplicitamente a ciò, e anzi sembri negarlo – “ci sarebbe capacità di dire ma non si trova | il luogo la sala l’uditorio sono tutti distratti” (p. 54) – che cosa se non la poesia può ancora creare un“foro nel silenzio”, porre in mezzo al rumore quelle tre vecchie, primitive domande frontali? – Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? – Giacché, in questo viaggio al termine del capitalismo di inizio XXI secolo e del (non)homo che ha forgiato, scopriamo che tutte le altre
“palafitte-risposte cedono ammarcite
nell’impaludarsi ansiogeno dei secoli affollati
(bisogna fare qualcosa velocemente bisogna farsi)
il futuro ci rincorre come un boa nella palude
da dietro da davanti” (p. 53)
Se volessimo provare a individuare i motivi ricorrenti di questa raccolta d’esordio, direi che essi sono essenzialmente quattro: 1)La tristezza per il sempre uguale, per l’infinitamente ripetuta visione del “piatto equivalere” di tutto ciò che ci scorre davanti – che si scrolla davanti, anzi -; 2)La devastazione ambientale come presupposto necessario di ogni possibilità di racconto di una crisi di civiltà; 3)L’impossibilità di non vedere, la scelta di guardare e il coraggio di osservare lo svanire nell’aria di tutto ciò che una volta era solido; 4)L’ardua ricerca di una via d’uscita e di compagni di evasione. A ciascuno di questi quattro punti sono dedicati i successivi paragrafi.
Questa grigia innocenza che inermi ci tiene
Se la perfezione coincide con l’assenza di desiderio, con uno spontaneo desistere da ogni moto ulteriore, Scapecchi ci invita a meditare il costo che comporta abitare nel migliore dei mondi invivibili, perfettamente realizzato. “Costretti ad uno stesso essere appagati” (p. 10) e “sempre contenti di essere tristi | di squadernare tristi narcisismi” (p. 15),i liberi servi pienamente inclusi e compartecipi della forma di vita occidentale occupano ancora un volume nel mondo, ma non lasciano altre tracce della loro presenza se non il cumulo dei loro rifiuti e i dati della loro navigazione sulla rete. L’alienazione digitale e lo spettacolo delle merci sempre disponibili sono qui additate a responsabili dell’incapacità, sempre più profonda, di trovare insopportabile il dolore altrui. Il prezzo della serialità è infatti il disgusto verso gli altri, e soprattutto degli altri come riflesso di sé stessi. Nausea come reazione necessaria al senso di squallore e sudiciume a cui si riduce la comunicazione:
“i rapporti con i nostri simili
(prende l’orrore al pensiero che il nostro stare
così sia replicato in miriadi di solitudini)
sudici e scadenti e ipocriti […]
di prevaricazione in prevaricazione passa
la nostra comunicativa
la nostra pubblica piazza affollata
da insensatezze di gusto breve
dimenticabili già dimenticate qui nessuno
stile (per questo tutti gli stili)
una continua replica del già visto” (p. 16)
L’indolenza e l’accidia diventano così i sentimenti caratteristici di un tipo umano senza qualità, senza coscienza di sé, senza desiderio, che “dal dolore asporta anche se stesso” (p. 25): “siamo carne da lavoro siamo carne da lavoro | è ancora oscuro quello che vogliamo | accumulare è meno faticoso che desiderare” (p. 19).Di pagina in pagina e di verso in verso, l’autore ci fa balenare davanti, per squarci, la condizione di “chi sta male pure stando al gioco dal lato giusto”(p. 25), della massa di individui consumatori “attorniati da cose con un codice – non un cuore” (p. 18) e perciò “sempre più e tristi deboli isolati | sempre più e eccitati esuberanti” (p. 22). Dissolte tutte le aggregazioni collettive, rimangono gli sciami delle folle solitarie “in questa rete di reazioni sempre immersi” (p. 16), a contendersi gli avanzi di sopravvivenza (e di distrazione) su un pianeta al collasso. “Turisti che disperano scoprendo | di avere un tempo libero e che tutte le città sono la stessa” (p. 40) come perfetto ritratto degli ultimi uomini:
“Il nostro immobilismo ci squarcia il petto come una granata
e noi ridiamo e beviamo e balliamo
davanti alla nostra sconfitta
siamo arguti e brillantemente ironici
parliamo parliamo e non produciamo più
simboli – il grembo è vuoto anche se
la ricchezza non è mai stata tanta come adesso.
Il nostro immobilismo tollera qualsiasi nefandezza
tutto ciò che facciamo che ci è intorno
in questa paura in questa usura in questa iattura
sozzo di sterco diabolico si perverte
quello che siamo lo decide il compromesso
il nostro immobilismo ci squarcia il petto come una granata.” (p. 27)
Mentre il mondo brucia, noi passiamo
“Si cerca di dimenticare questo triste accumulo
di atti, di cose, di fatti. L’illusione
yogica di essere vicini al niente
approssimarsi alla conquista del deserto.
Non siamo mai stati più distanti di adesso
dall’annullamento di se stessi
le nostre carni secernono protesi di litio,
di silicio, di cobalto, si sfilacciano
in liquide escrescenze deturpano
tutti gli angoli del pianeta triturano
internano e torturano l’esistente
ma siamo bravi a dimenticare questo triste sogno
tante realtà raffazzonate e scaltre
rappresentano una rassicurante scorciatoia
ogni dovere succhia il nostro oro giornaliero
che non si guadagna e altri ameni spettri e stordimenti
e chi si interroga o più semplicemente soffre
si scorda del suo male con vecchi rimedi
nuove droghe visive. Non c’è incubo
che valga questo triste sogno.
Poi nelle private stanze, negli uffici, nei cantieri,
lungo i distesi templi delle strade
sbattiamo con dolore negli improvvisi
spigoli affilati delle nostre merci.” (p. 32)
Quasi assumendo i panni di un Eliot marxista, lo sguardo di Scapecchi ci costringe a guardare le ferite di una terra devastata da chi non sa più farne un uso misurato, e perciò la usura sempre più, con sempre più dismisura. Queste ferite, sono le infrastrutture costruite per estendere e intensificare la connessione (possibilmente inesausta) dell’intero pianeta alla società dei consumi. Le navi portacontainer, le sonde spaziali, “il dio rarefatto e scaltro, il dio algebrico e falso” (p. 38) dell’intelligenza algoritmica assumono qui i tratti di forze mostruose e implacabili da cui dipendiamo, una sfida continua ai regni dell’acqua, del cielo e della mente, in cui persistiamo incapaci di trarre le dovute conseguenze dall’incendio che cresce. Consumatori impenitenti di luoghi deceduti, di esperienze impoverite e di cose scadenti, siamo sfiorati ma ancora in nulla smossi dalla consapevolezza della nocività del nostro ordine, dalla sinistra affinità, ad esempio, “tra turismo e terrorismo” (p. 40). Nel segno di Yeats – “tutto cade. a pezzi. è caduto. non tiene il centro.” (p. 22) –, viene squadernata provocatoriamente di fronte a noi tutta l’inanità del nostro progresso: come tanti bambini giunti alla bella maturità del farsela addosso senza lamentarsi, lordiamo la terra dei nostri veleni e rifiuti – “noi che soli incastrati nei detriti noi che soli | non sappiamo smaltire i nostri scarti” (p. 22) – , finché non ci sarà più niente da sporcare, nessuno spazio altro da trasformare nell’ennesima discarica: “in realtà non sappiamo più | organizzare un regime di senso che verrà | in realtà tutto muore | di una morte sempre più sporca e simile alla nostra” (pp. 38-39).
Si arriva dunque a rimpiangere il paradossale maggior controllo sulla natura promesso dalle religioni pagane, a cui bastava un singolo sacrificio per credere di poter far cessare o scongiurare la catastrofe; “ora non ci basterebbe una carneficina” (p. 22). Prevale quindi il senso di deriva verso uno schianto finale, la percezione di un’estenuante dissolvenza che potrebbe rinviare (per l’efficace ricorso ai puntini di sospensione e alla disposizione grafica del testo sulla pagina) ad alcuni drammi di Beckett, come in questo testo ipnoticamente e cupamente oracolare:
“. . . arcipelaghi distrutti . . . ed oltre ancora andare
. . . in via di estinzione . . .
terre alla deriva galleggiare . . .
. . . dalla creazione . . . foro nel silenzio . . .
risentimento . . . per fare fronte a . . .
e loro dicono che bisogna credere . . .
. . . pieni di pastori, senza alture . . .
per loro bisogna credere credere . . .
. . . tutto questo scoramento . . .
. . . con le spalle voltate . . .” (p. 33)
La voce poetica non rinuncia tuttavia a interrogare apertamente la misura di una collera necessaria, di una conversione di segno e direzione di quella violenza sistemica e silente su cui si regge il perpetuarsi di “un’ingiustizia totale”: “e ora quanto | quanto adesso servirebbe quanti incendi | quanto fuoco nelle case nei castelli di chi ha | quanto il terrore che adesso serve per le strade?” (p. 23).
Avere tutta la chiarezza e scarseggiare di lucidità
“finalmente siamo costretti a guardare
finalmente siamo costretti
a spaccarci gli occhi sull’offesa
ma questo non basta non è mai bastato bisogna
avere esperienze strusciare la carne
ferirsi e distillare tutto questo con ragione” (p. 10)
In perenne e reciproca tensione, lo sguardo e la voce sono le due dimensioni sul cui malfunzionamento collettivo insiste il dettato poetico di Scapecchi. In un’epoca che ha reso l’immediatezza e la rapidità dei valori da celebrare, occorre fare i conti con il restringersi di quella camera di filtraggio, di quegli interstizi di solitudine e silenzio tra la visione e la parola che permettevano di elaborare una comprensione di quanto si aveva davanti; di produrre, magari un movimento che lo mutasse. I social network sono i principali imputati del senso di impaludamento che sperimentiamo e l’autore ce li rappresenta infatti come una gigantesca camera dell’eccesso – “Su di una sedia vedere e inorridire | aggiungere reazioni sensazioni sul momento” (p. 10) – e di un godimento turpe perché impostoci, perché annichilente. L’immagine dell’“occhio spalancato sulla propria reale condizione | miope galleggiante in acque opache” (p. 12) evoca la cecità anche fisica che il prolungato contatto con gli schermi a cristalli liquidi produce in noi, il peccato profondo di tanti Edipo che il nostro Tiresia si fa carico di mostrarci: “invano ci alleniamo a non vedere | perché ciechi negli occhi negli orecchi nella mente | per la troppo luminosa evidenza” (p. 25). Eccolo, il peccato: la “cura Ludovico” a cui l’Alex dei nostri giorni viene sottoposto (sempre con il suo consenso, non compare forse il tasto “Accetta” ad ogni nuova diapositiva?) non punta a purgarlo dalle pulsioni antisociali e violente che albergano in lui, bensì vuole, con gli stessi identici mezzi, renderlo insensibile al dolore degli altri, prevenendo l’azione morale. Come al personaggio di Burgess e di Kubrick si vorrebbe precludere la possibilità di fare il male (e dunque, inevitabilmente, anche la facoltà di scegliere il bene), lo stesso tende ad accadere all’individuo oggi sempre connesso e radicalmente separato dalla sorte dei propri simili.
Appare vano immaginare una via di fuga, quando “nessuna verità è più al sicuro | tradita appare ogni tradizione” (p. 8). Due versi terribili, che interrogano l’aver smarrito gli strumenti del pensare contro, il non essere riusciti a proteggere quelle verità a cui alludeva il testamento poetico di Fortini, come pure l’aver trascurato (magari anche in tante celebrazioni nostalgiche e stantie) quella tradizione degli oppressi che costituiva, per Benjamin, la migliore fortezza soggettiva per attraversare i tempi bui senza farsene sopraffare.
Eppure, con un volontarismo disperato, la voce del poeta-profeta non rinuncia a un invito all’agonismo, senza però saper indicare un vero e proprio campo di diserzione, una comunità o una classe redentrice e vendicatrice:
“come sempre chi prega è scacciato come un ladro
chi ha una voce se l’è dovuta inventare
contro i sudici rapporti con i nostri simili
si deve lottare veramente
si deve lottare veramente contro” (p. 17)
L’alfabeto di questa voce da reinventare, capace di ferire e far attrito sulla superficie liscia del presente, per Scapecchi potrebbe forse provenire dalla filosofia, dall’antica sapienza eraclitea agli scritti di Debord e Deleuze, passando per la moderna teoria del divenire storico di Marx (il cui Manifesto è ripetutamente citato in molti incipit). Una lingua straniera, quella del pensiero, e come tale riportata sotto forma di intermezzo all’interno della prima sezione.
Non io, non noi, forse tu. La possibilità di una via d’uscita
Avere esperienze, strusciare la carne, ferirsi e distillare tutto questo con ragione, dicevamo. Ma chi può farlo, chi deve farsene carico? Non il poeta-profeta. Chi lo ascolta, forse. Chi ascolta la voce muta delle cose. Si tratta di innescare un movimento contrario a quello dell’accumulo, sottrare e sottrarsi al funesto incantesimo della società dello spettacolo social. Questo tra le righe suggeriscono, come coperti rintocchi, i riferimenti a un tu dai tratti a volte imperativi – “non contraddire la realtà | […] non contribuire ad allargare l’ombra tanto lunga” (p. 21), in altri casi di pacato invito a fare i conti con il nostro essere complici della disumanizzazione del mondo, con la miseria dei nostri destini generali attuali:
“siamo carne da cannone nel tuono delle merci
rigogliosa amazzonia di prodotti di commerci
è squallido parlare con gli oggetti specialmente
se questi ti rispondono” (p. 19)“Sei forse tu il punto più depresso di questa depressione
il magno imbuto dove tutto scivola nel sedimento
dei secoli artefatti una vallata
sotto il livello del vivibile” (p. 31)
Praticare esercizi di decentramento (ovvero l’esatto contrario del subire la dispersione) personale o di specie, assumere che “non siamo noi il centro del ricamo” (p. 36). Riprendere familiarità con la noia e col vuoto come elementi necessari a ripristinare il desiderio e il bisogno di un incontro. Allargare e far durare questi spazi di riparo, “nell’eterna incertezza nell’eterno movimento | di attori disperati e di spietati direttori” (p. 40). Far sì che anche se “tutto svanisce tutto se ne va | gli arrabbiati restano.” (p. 41) Tenere sotto tiro la possibilità di una “piccola gioia”. Questa la pars construens ricavata, non dichiarata, da questi testi. È forse poco o forse è tanto. Certo è che anche solo per pensarla, per immaginarla, c’è bisogno che gli strumenti umani siano posti di fronte alla vetrina ritornata deserta. Ha scritto T. S. Eliot nei Quattro quartetti: “Se tutto il tempo è eternamente presente, tutto il tempo è irredimibile.” C’è dunque ancora bisogno di qualcuno che gridi a tutti il nulla che c’è, che sussurri almeno a qualcuno il nulla che non c’è, perché nell’oggi possano comparire e ricomporsi delle traiettorie di redenzione. Forse allora, come già fu, sapremo nuovamente dire, o persino cantare: nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia.